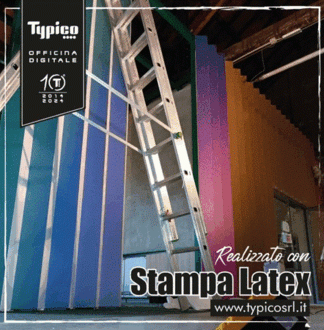23 Gen 2018, 14:25 | Attualità | Scritto da : Alice Ravazzini

L’insieme dei paesaggi presenti nelle colline di Scandiano, Albinea, Quattro Castella e Bibbiano offrono panorami caratterizzati da un dolce e fitto susseguirsi di pendii dove le viti, non solo la Spergola, godono di condizioni climatiche ottimali. La preziosa escursione termica permette all’uva di maturare progressivamente e la privilegiata esposizione ai raggi solari dona morbidezza agli acini. Inoltre una perfetta areazione e la variegata e ricca composizione dei terreni completano le prerogative fondamentali che sono a garanzia di una produzione di qualità nel rispetto della natura.
Il vitigno Spergola non ha bisogno di grandi quantità di acqua dal momento che la pianta la ricerca in profondità affondando le radici in terreni ricchi di struttura e sostanze che vengono assimilate al frutto. Esso a sua volta assume un gusto unico che lo caratterizza e lo rende unico. Ma la particolarità di questo vitigno non è da ricercare soltanto nel suo gusto, ma anche nel suo aspetto. La Spergola è infatti chiamata anche “alata” per il fatto di possedere un piccolo grappolo che si collega con un pedicello al grappolo principale creando una sorta di “ala”. I grappoli a loro volta si presentano mediamente densi, con acini di media/piccola grandezza, buccia pruinosa di un caratteristico colore verde tendente al giallo.
Il nome “vitigno Spergola” ha radici antiche. Si ipotizza che “spergola” sia l’aggettivo con cui veniva definita l’uva per il fatto di presentare un grappolo “un po’ spargolo”, cioè diradato. Nel corso dei secoli è stata chiamata in vari modi (pomorina, pellegrina e spergolina), ma resta sempre un’uva a bacca bianca rinomata per la sua spiccata acidità, freschezza e mineralità.
L’uva Spergola ha quindi radici antiche della cui trasformazione in vino però per molto tempo hanno goduto soltanto gli abitanti di Scandiano. I più invece l’avevano relegata ad essere un’uva da taglio o da esportazione, confondendola con una sottovarietà del Sauvignon Blanc. Il tutto nonostante con tale vitigno avesse poco o nulla in comune. Lo avevano capito i produttori locali che hanno sempre creduto nella potenzialità del frutto e si sono impegnati per restituire ai lumi dell’ampelografia e dell’enologia moderna un vitigno autoctono altrimenti dimenticato. Fino a non molto tempo fa le cassette di Spergola partivano per il Nord Italia e l’uva veniva utilizzata per i vini frizzanti e gli spumanti più famosi del Paese. Al contrario quella che veniva imbottigliata localmente al 100% nella sua versione spumantizzata veniva chiamata affettuosamente dagli scandianesi “Champagnino”. L’equivoco con il Sauvignon Blanc si risolse grazie alla scienza e alla perseveranza dei produttori. In particolare il Comune di Scandiano e le quattro cantine fondatrici della Compagnia della Spergola incoraggiarono uno studio biologico e genetico dell’uva che culminò nel 2004 quando la professoressa Fontana dell’Università degli Studi di Bologna riuscì a isolarne il gene. Oggi quindi l’uva non parte più per destinazioni sconosciute, ma resta dove si produce. Un’area che comprende l’intero territorio dei comuni collinari di Scandiano, Albinea, Bibbiano, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Montecchio, Quattro Castella, San Polo d’Enza, Vezzano sul Crostolo, Viano e parte dei territori dei comuni di Reggio Emilia, Casina e Sant’Ilario d’Enza.